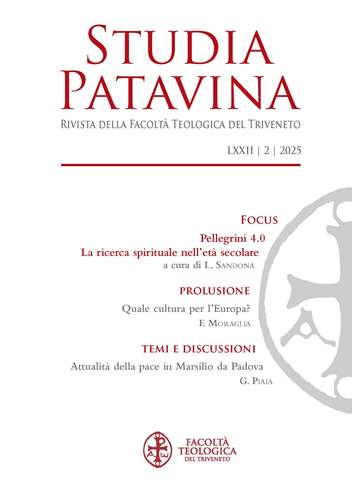Pellegrino, nomade, migrante, camminatore, cercatore di senso, viandante: sono molte le categorie che provano a inquadrare l’uomo in movimento fin dall’antichità; categorie che non si oppongono ma si inseguono in ognuno di noi e sono spesso compresenti in modo esplicito o implicito.
A quest’ambito, nell’anno del Giubileo, la Facoltà teologica del Triveneto ha posto attenzione già con un convegno, nel marzo scorso, dal titolo In cammino. Pellegrini e pellegrinaggi. Ora, a partire da una lettura integrata delle diverse figure che abitano i camminatori, la rivista Studia patavina affronta la tematica con un Focus che offre sguardi di taglio storico, spirituale, antropologico-liturgico ed estetico-psicologico. L’approfondimento, dal titolo Pellegrini 4.0. la ricerca spirituale nell’età secolare, è pubblicato nel n. 2/2025.
«Il recente ritorno di interesse per i cammini e i pellegrinaggi – spiega Leopoldo Sandonà, docente della Facoltà, che ha coordinato il focus – interroga una dimensione insieme antropologica e religiosa ben radicata nella storia dell’umanità. Del resto, i principali cammini che solcano il continente europeo rimandano a questa storia più che millenaria nella triplice direzione di Gerusalemme, Roma e Santiago de Compostela». Andare all’origine significa trovare un riferimento per l’oggi, anche in relazione alla spiritualità, spesso non identificabile in categorie tradizionali. «La spinta del camminatore e del pellegrino – aggiunge – è oggi spesso e volentieri animata da dinamiche che, pur non essendo contrarie alla fede, nascono anzitutto in chiave personale ed extra-istituzionale, alla ricerca però di una comunità perduta e di una condivisione di interessi, ma anche di impegno, che può tramutarsi non di rado nello stesso impegno ecclesiale e pastorale». Sotto l’aspetto antropologico e liturgico il pellegrinaggio e l’accesso ai santuari si configurano come «esperienze liminali dell’umano, esperienze di transizione e di passaggio, di penitenza, conversione e trasformazione, non solo nelle forme tradizionali ma anche incarnate in molte espressioni artistiche, letterarie, cinematografiche all’interno della contemporaneità». Riportate alla loro origine, queste esperienze possono ritornare a essere luoghi di vangelo, da cui sempre nuovamente scaturisce nei credenti il «cambiamento di vita che il cammino in sé e come metafora dell’esistenza, consente di sperimentare».
Il Focus è articolato in cinque contributi. Luciano Bertazzo (Centro studi antoniani) delinea lo sviluppo del pellegrinaggio nel tempo, dai due epicentri iniziali, Gerusalemme e Roma, e successivamente Santiago de Compostela, passando per lo stallo dell’epoca umanistica che privilegiò invece l’interiorità come luogo di devozione, fino all’emergere della dimensione mariana nei santuari di Lourdes, Fatima e Guadalupe (Per una storia del pellegrinaggio nella tradizione cristiana). Il rapporto fra nuove spiritualità e nuove forme di pellegrinaggio è declinato da Marzia Ceschia (Facoltà teologica del Triveneto), che ne coglie le sfide per la riflessione teologica, specialmente in relazione alla virtualizzazione delle esperienze (Pellegrinaggi contemporanei, tra nuovi paradigmi e nuove spiritualità). Le recenti indagini sociologiche dimostrano che la religiosità popolare del pellegrinaggio è cresciuta in Italia, ma è cambiata la forma del pellegrinaggio: da comunitaria è diventata individuale, come spiega Alessandro Moro (Ufficio della pastorale del turismo e pellegrinaggi, Diocesi di Concordia-Pordenone) nel suo contributo (Il pellegrino postmoderno e la ricerca del sacro). Francesca Leto (Istituto superiore di Scienze religiose “Mons. A. Onisto”, Vicenza) descrive la sequenza spaziale del pellegrinaggio, nel quale la metafora dell’homo viator recepisce e interpreta le caratteristiche essenziali e i moti più profondi dell’homo religiosus (Spazio sacro e architettura del pellegrinaggio). Completa il quadro Angelomaria Alessio (Istituto Liturgia Pastorale S. Giustina, Padova), con un’analisi della dimensione artistica del viaggio sacro e della trasformazione psicologica del pellegrino, senza dimenticare le implicazioni culturali, sociali ed economiche del fenomeno del pellegrinaggio (Estetica e psicologia del pellegrinaggio: dimensioni artistiche, letteratura, cinema).
Oltre al Focus, Studia patavina riporta la lettera scritta da papa Francesco alla Facoltà in occasione del suo ventennale (2005-2025); accanto a questa, si può leggere la prolusione Quale cultura per l’Europa? Ragioni di speranza nel tempo dello smarrimento: interpretare il presente, progettare il futuro, tenuta al Dies academicus dal gran cancelliere, mons. Francesco Moraglia.
La rivista propone inoltre i seguenti articoli: In dialogo con Bruna Bianchi. Note a margine di «Non resistere al male con il male». Obiezione di coscienza e pacifismo nel pensiero di Tolstoj, di Isabella Adinolfi; Joseph Ratzinger e la fede nella Verità, di Antonio Ricupero; La “doppia” attualità del tema della pace in Marsilio da Padova, di Gregorio Piaia; L’enigma di una fede resiliente. Davide Zordan e il futuro della teologia, di Paolo Costa.
La sezione dedicata ai libri si apre con una rassegna bibliografica sul tema La presenza e il ruolo delle donne nella chiesa, curata da Marzia Ceschia e Assunta Steccanella; segue una ricca selezione di recensioni e segnalazioni.
Il fascicolo 2/2025 può essere richiesto (al costo di € 17,00) a studiapatavina.abbonamenti@fttr.it
Paola Zampieri